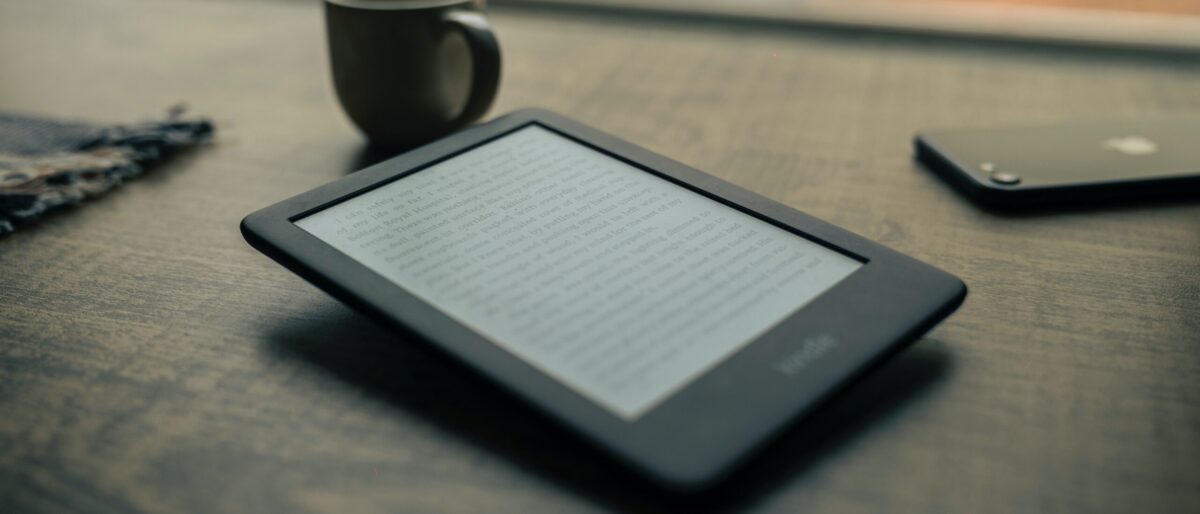Nascono sempre più influencer, reali o direttamente digitali. Del resto, se c’è una (più o meno intelligente) IA a sviluppare identità associabili alla nostra, perché dobbiamo preoccuparci del corpo fisico che ci lega a questa Terra?
Facciamo un esempio. Aitana Lopez non esiste nella nostra realtà fisica. I suoi piedi non poggiano più o meno delicatamente sul suolo terrestre. Ma lei (o essa?) esiste sui social. Esiste digitalmente con effetti diretti sul mondo reale, quanto meno dal punto di vista economico, ma effettivamente anche emotivo, sociologico (e quindi giuridico).
Aitana è una delle tante influencer generate dall’IA che spuntano come funghi sottraendo follower a influencer un po’ più reali, perché (più o meno) speculari al mondo analogico.
Occupandoci di influencer non possiamo non ricordare di quanto riferito tempo fa da Umberto Eco: «i social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli». L’era degli influencer, dell’informazione “usa e getta”, senza attenta verifica delle fonti, protesa in ogni (brevissima) frase a stupire, a dividere (divide et impera) e a proferire assiomi, ci sta facendo probabilmente involvere culturalmente e forse anche giuridicamente.
La complessità (anche nell’uso della lingua) è servita in passato a fare germogliare le nostre menti, a fare sviluppare i nostri cervelli (naturali). Oggi tutto invece viene plasmato di semplicismo nella foga di ricevere un like in più.
Leggere con calma. Aspirare alla lentezza di un’interpretazione meditata. Tornare a uno “slow food culturale” spero che inizi prima o poi a tornare a essere una necessità diffusa (e insegnata). Un po’ come il ritorno del vinile, spero che si ritorni al senso della riflessione profonda, che si arrivi anche mesi dopo su una notizia, per comprenderla profondamente. E questo elogio della lentezza forse dovrebbe caratterizzare le azioni del legislatore e delle Autorità preposte a regolamentare alcuni settori specifici nel nostro Paese.
Fatte queste doverose premesse, che possono riferirsi sia agli influencer reali sia a quelli digitali sviluppati attraverso le app di IA, proviamo a riflettere appunto sulle ultime novità normative che riguardano questo tema.
Fermo restando che esistono anche attenti studiosi o riconosciuti artisti che influenzano semplicemente grazie alla cultura che esprimono in post, podcast o video sviluppati professionalmente, la mia reale preoccupazione è che essi possano finire per rivelarsi a lungo andare come una specie in via di estinzione, considerato l’attuale proliferare di casi come il “pandorogate” che un paio di mesi fa ha appassionato mezza Italia (e l’altra metà – spero – un po’ meno) e tale inchiesta ha comportato sia notevoli problemi a Chiara Ferragni (anche dal punto di vista sentimentale a quanto pare) e sia (ed è quello che più interessa ai nostri fini) ha determinato novità immediate dal punto di vista normativo.
Come giurista non posso non avvertire un certo malessere quando casi del genere sembrano incidere sulle priorità del legislatore nazionale portandolo a decidere di intervenire in fretta e furia su “pericolosissime” problematiche come quella degli “influencer che influenzano” un po’ troppo l’inebetito popolo del web e del social web.
In pochi giorni, infatti, si è deciso di intervenire sia con la legge 27 dicembre 2023, n. 206 (che contiene disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, ma anche una definizione specifica per i “creator digitali” e l’istituzione di un repertorio dei loro contenuti nel registro pubblico generale delle opere protette) e sia con le Linee Guida di AGCOM proprio sugli influencer.
Lo scorso 10 gennaio 2024, in particolare, il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), ha approvato all’unanimità il testo delle “Linee-guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del Testo unico da parte degli influencer e istituzione di un apposito Tavolo tecnico”, volte proprio a garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e, cioè, del Testo unico sui servizi di media audiovisivi, prevedendo anche per loro precise responsabilità editoriali sui contenuti condivisi sulle piattaforme (analoghe a quelle dei fornitori di servizi di media audiovisivi).
Giusto per evitare fraintendimenti su ciò che sto cercando di sottolineare, premetto che so bene che – a guardare con attenzione i tempi e le modalità di promulgazione delle Linee Guida di AGCOM – esse non sono nate effettivamente come diretta conseguenza del “pandorogate”: le consultazioni pubbliche relative a tale regolamentazione erano state aperte già svariati mesi prima, ma – possiamo dircelo con franchezza – senz’altro alcuni episodi di cronaca, soprattutto se riferiti al “misterioso” mondo del digitale, sembrano essere in grado di sbloccare sistematicamente alcuni iter burocratici che riguardano atti di rilievo giuridico.
Inoltre, sempre per evitare misunderstanding su ciò che sostengo, credo che sia corretto rimarcare che coloro che chiamiamo influencer (e a cui si riferiscono le Linee Guida di AGCOM) non coincidono perfettamente con i creatori digitali previsti invece dalla legge 206/23. I rispettivi testi hanno finalità di azione ben diverse, ma – allo stesso modo – non si può non riferire che il “creator digitale” può essere a sua volta influencer, se rientra nei parametri individuati dalle Linee Guida di AGCOM. E né voglio evidenziare che il mondo degli influencer debba essere ignorato dal legislatore nazionale o europeo…il problema è che non credo assolutamente che il diritto debba inseguire ex lege ogni novità, sull’onda degli stimoli della cronaca.
Io sinceramente sarei intervenuto prima di tutto culturalmente sia sui fruitori di tali contenuti “creativi” e sia sui fornitori degli stessi. Perché c’è profonda necessità di investimenti educativi, piuttosto che di nuove norme, soprattutto nei nebulosi ambiti della digitalità.
Ma abbiamo deciso di intervenire prontamente con Linee Guida che spartissero nettamente i confini tra chi possa definirsi influencer in Italia (per numero di follower) e chi no, con regole di trasparenza, codici di condotta ed ennesimi tavoli tecnici…infatti, inevitabilmente, al fine di regolare al meglio l’attività degli influencer, l’Autorità ha deciso di istituire un apposito Tavolo tecnico, il quale dovrà provvedere a redigere la regolamentazione di uno o più codici di condotta con ulteriori misure e modalità mediante le quali gli influencer dovranno adeguare la propria attività al fine di garantire il rispetto delle disposizioni applicabili del Testo Unico.
Un ennesimo rebus normativo che aggiunge confusione a un sistema di regolamentazione che ben si ritrova ancora oggi nelle profetiche parole di Tacito: “corruptissima re publica plurimae leges”.
La legge 206/2023, invece e come anticipato, nell’art. 27 ci ha regalato la definizione di “creator digitale” che è un “artista” che sviluppa opere originali ad alto contenuto digitale. Un menestrello, un poeta, un pittore, quindi, che per il secondo comma di questo articolo può decidere di depositare i suoi “preziosi” contenuti creativi in un repertorio, cioè un registro pubblico di opere protette. Quindi, nel mondo dei registri distribuiti, dei sistemi di conservazione dei documenti informatici, di marche temporali e dei servizi di recapito certificato, ci rivolgiamo a un repertorio per tutelare con data certa questi flussi informativi costanti che piovono nel mondo dei social.
Tutto appare piuttosto surreale sinceramente.
E intanto noi giuristi rimaniamo con i nostri dubbi amletici da decifrare:
Chi è Aitana Lopez?
L’artista o l’opera da tutelare?
Chi è il “creator digitale”, in questo caso?
La società che ha deciso di crearla o l’intelligenza artificiale che l’ha prodotta?
Cosa e chi infiliamo in questo fantomatico registro da costruire a tutela del “made in Italy”?
Stiamo affrontando tali delicate tematiche come goffi elefanti che si aggirano in un negozio di cristalli. Forse, dovremmo osservare di più e legiferare un po’ di meno per evitare altri danni al nostro cervello naturale.
Auguriamoci insomma di continuare a usarlo il nostro cervello naturale per i prossimi anni, anche in punto di diritto.
L’articolo è apparso originariamente sulla Rivista “Reputation Today”